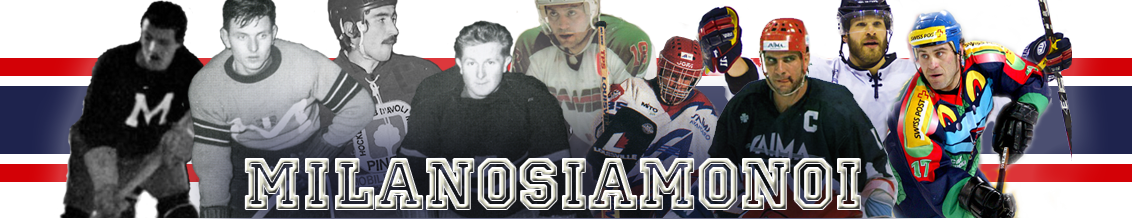I gladiatori del sottozero
di Bruno Raschi*
tratto dalla rivista “Sport in medici domo” del dicembre 1954
Quella sera i “ Leoni di Wembley” erano più cattivi del solito. E’ un grosso difetto per un hockeysta essere più cattivo del solito. In genere chi sceglie quel mestiere, chi accetta la battaglia sulla pista di ghiaccio con il bastone in mano non dev’essere cattivo per vizio di natura, e il cattivo lo deve fare solo per finta dal momento in cui, calzati i guanti, esce dallo spogliatoio e si imbatte già per la strada con il suo avversario. Sa già per esperienza, per spontanea accettazione, che l’hockey è un conto di dare e avere, di colpi presi e di colpi dati. E il bilancio in questi casi è sempre un incerto. In sessanta minuti di gioco le ossa scricchiolano almeno una volta e qualche volta cedono. In questo caso dalla pista si finisce per direttissima all’ospedale. Poi, appena guariti, si ritorna in pista, buoni per un’altra volta. In genere chi ha colpito non lo ha fatto apposta, è un nome e una fisionomia da dimenticare.
Ma quella sera i “Leoni di Wembley” erano cattivi davvero, pareva lo facessero apposta. Varcata la Manica, si erano fatti vedere sulle più famose piste del Continente e dappertutto avevano vinto. Solo che mano a mano che il loro carnet di viaggio si infittiva di vittorie, la vita pareva farsi più difficile. E la gente dappertutto dove arrivavano voleva vederli battuti. Freddi per natura, il loro sangue aveva cominciato a bollire mano a mano che discendevano verso il Sud. I primi episodi di conflitto s’erano trovati di fronte ai “canadesi” di Zurigo e di Losanna. Di colpo per i “Leoni di Wembley” l’atmosfera s’era fatta pesante: nove a cinque per gli svizzeri. Ma non tutto era filato liscio. I bastoni avevano cominciato a ruotare al di sopra delle spalle, i pattini avevan fatto scintille. In Italia la musica continuò.

Anche in Italia v’era una legione straniera alla quale i leoni bianchi in campo rosso non facevano paura. Battuti a Losanna, quei leoni pareva avessero attenuato il ruggito. Anche alla gente pareva così. Successe il contrario. Uno a uno alla fine del primo tempo. Era appena suonato il gong della ripresa che Davidson fuggì in contropiede come una furia col disco incollato alla fettuccia rossa del bastone. Tucci lo inseguì e lo raggiunse sulla linea bleu atterrandolo di forza. Finirono entrambi a terra. Mentre l’italiano s’alzava, l’anglo-canadese con mossa rapida, traditoresca l’afferrò per la nuca e lo spedì col naso in giù a fiutare la polvere del ghiaccio. Fu il segno della battaglia. I giocatori buttarono i bastoni, si sfilarono i guanti e fecero della pista un ring panoramico aperto da tutti i lati allo spettacolo. Durò la rissa qualche minuto con tutta la gente in piedi ad incitare i combattenti. Gli arbitri attesero, provvidero alle espulsioni, si prepararono a un nuovo ingaggio. Il gioco riprese con la gente eccitatissima che invocava ancora le botte. Ma di botte non ve ne furono più. Era bastata una scarica, uno scambio rapido di idee. Poi Davidson aveva scordato Tucci, Tucci aveva scordato Davidson. I “Leoni di Wembley” segnarono una, due, tre volte e vinsero la partita.
E la gente? La gente s’ammansì a poco a poco, senza accorgersene, capì la lezione. Se ne andò salutando, battendo le mani ai “Leoni di Wembley”. Un episodio. Una storia vera che spiega da sola l’hockey su ghiaccio, uno degli sport più belli del mondo. L’hockey su ghiaccio infatti va spiegato così con un paradosso, con una rissa ed una pace, fatta d’incanto, per moto quasi spontaneo, magari senza l’intervento della polizia, con gli arbitri che stanno ad aspettare che tutto finisca per riprendere il gioco. I duellanti che vengono espulsi s’allontanano dal campo per cinque, dieci minuti, un quarto d’ora e vanno a sedersi sovente l’uno accanto all’altro nei posti di “prigione” senza scorta preventiva. Ed anche la gente si riconcilia poco a poco, osservando il gioco, presa nel vortice della velocità, impegnata con gli occhi nella caccia al disco.
Questo è l’hockey: velocità, colore, brivido, fantasia. Chi non lo ha visto difficilmente lo immagina più bello di quanto sia. Colore. Gli uomini dell’hockey sono uomini colorati che ricercano un primo effetto nella composizione delle tinte più accese e contrastanti d’una tavolozza: il bianco e il rosso, il verde prato e il giallo, l’azzurro cielo e l’arancione. Chi li vede entrare in pista in fila indiana per la fantasia d’apertura deve stropicciarsi prima di tutto gli occhi. Poi, secondo effetto, deve avere un poco di paura. Quella degli hockeysti è un’armatura strana, quasi grottesca che par fatta apposta per far paura alla gente. Guantoni, corazza, spalliere, parastinchi e paragomiti, mutandoni semirigidi imbastiti con le stecche di bambù. Paiono guerrieri d’un altro secolo: sostituiti i bastoni alle spade potrebbero assomigliare nel loro strano atteggiamento ai gladiatori di Roma.
Un doppio effetto, squisitamente psicologico, è già raggiunto. La gente è costretta istintivamente al tifo acceso, cattivo, come quello che s’agitava duemila anni fa nelle arene. Più frequenti saranno le mischie, più fragorosi saranno i “bodicech”, più la gente sarà contenta e, chiederà la vittima. Ma se i contatti violenti, la lotta gagliarda costituiscono elementi quasi patologici di grande effetto, il vero segreto dell’hockey è la velocità.
La velocità è il correttivo dell’agonismo. L’uomo investito ai quaranta l’ora, che va a infrangersi contro la balaustra, non ha tempo di riflettere sul male, non ha tempo di guardare in faccia l’avversario che ha colpito. Deve alzarsi il più in fretta possibile e cercare il disco, o il bastone se l’ha perduto, riprendere la sua posizione di difesa o d’attacco. Da una sua incertezza può dipendere l’esito della partita. E il giro prosegue pazzo e frenetico per un’ora. Se v’è tempo di offendere, non v’è tempo per chiedere scusa. La pace la si farà alla fine. Fin che dura la lotta il cuore è il disco, un cuore duro di caucciù vulcanizzato.
La gente si esalta inebriata dal rischio e dalla velocità, una velocità sul filo dell’acrobazia che raggiunge limiti quasi inverosimili. Si calcola infatti che un hockeysta lanciato a piena azione raggiunga col coefficiente del peso la velocità di cinquanta o sessanta chilometri all’ora. Il disco nel tiro in gol diventa un razzo, può toccare il vertice dei 120 orari, più che bastevole quindi a spezzare a un giocatore la spina dorsale. Tali cifre già impressionanti di per se stesse, lo diventano ancor più quando si considerino le loro ripercussioni e i loro effetti sul gioco. Per parare un tiro a tre metri dalla porta il portiere ha circa un decimo di secondo di riflessi, per respingere uno shoot dal limite della zona d’attacco (linea bleu) non più di un secondo.

In questo violento succedersi di emozioni fatte di colpi sordi, di piccoli tradimenti ricercati, di reazioni violente, di acrobatismi che paiono impossibili, la gente passa dall’ira all’entusiasmo, all’emozione. Questo in sintesi, in rapide istantanee, è l’hockey su ghiaccio. Da circa mezzo secolo, come forma di spettacolo, lo si pratica in quasi tutte le regioni d’Europa. Il suo regno, il suo vero paradiso è però sempre il Canadà dove l’hockey è nato sul ghiaccio dei fiumi e dei laghi per ispirazione e merito dei ragazzini che coi pattini ai piedi andavano a scuola. Un bastoncino ricurvo, un colpo fortuito dato a un sasso rotondo…
Gli eroi dell’hockey bisogna dunque andarli a cercare laggiù sulle grandi piste coperte di Detroit, di Toronto, di Halifax, di Ottawa, di Niagara Falls, capaci ognuna di ventimila spettatori e gremite regolarmente per almeno cinque giorni alla settimana. Quando si giocano le partite della “Stanley Cup” – la più grande manifestazione americana cui partecipano solo sei squadre – l’entusiasmo e il tifo delle folle raggiungono vertici sconosciuti ai nostri stadi di calcio. La gente impazzisce per un posto in galleria, i poliziotti con i pattini ai piedi controllano la pista lungo tutto il perimetro.
Ogni generazione di campioni ha così i suoi miti. Uomini come Rocket Richard, Teeder Keenoy e “Boom Boom” Geifferon rimarranno famosi in tutti i tempi come demoni del ghiaccio venuti in terra a interpretare col bastone di hicory ricurvo la più diabolica magia. Tre uomini d’una tale forza sarebbero sufficienti a battere da soli le più agguerrite compagini europee. Ma simili giocatori l’Europa, lungi dal produrli, non potrebbe neppure “mantenerli”: i loro ingaggi raggiungono limiti proibitivi. Per le nostre scene sono sufficienti per ora i dilettanti della terza categoria. Basti dire che la squadra canadese scesa in Europa a disputarvi gli ultimi campionati mondiali, il “Lyndsthorm Motor Oil” (East York Lyndhursts Motor ndr) era una squadra di quarta serie. Rocket Richard, Teeder Keenoy e “Boom Boom” Geifferon dovremo accontentarci per ora solo al cinematografo per convincerci che esistono davvero e senza trucco. Si, anche “Boom Boom” Geifferon, il giocatore il cui tiro fa suonare le sponde della pista con l’effetto di una fucilata (di qui il soprannome), il giocatore che una sera, nessuno sa come, in dieci secondi segnò due gol.
* Biografia dell’autore tratta da Wikipedia

Bruno Raschi (Borgo Val di Taro, 4 dicembre 1923 – Milano, 2 maggio 1983) è stato un giornalista italiano.
Laureato in Lettere a Torino, per mantenersi gli studi aveva iniziato a lavorare a Tuttosport nel 1952. Nell’ottobre 1959 passò alla Gazzetta dello Sport, dove rimase per oltre vent’anni divenendone vicedirettore. Seguì le Olimpiadi di Roma e si occupò di calcio e pugilato, ma legò il suo nome e gran parte della sua carriera al ciclismo che lo vide per inviato complessivamente a 30 edizioni del Giro d’Italia e 18 del Tour de France. In particolare, al Giro, era stretto collaboratore di Vincenzo Torriani e partecipava regolarmente alle puntate del Processo alla tappa curato da Sergio Zavoli.
Godeva di grande rispetto e stima da parte dei colleghi, che lo soprannominarono “il Divino”. Nel 1977 ricevette il Premio Saint-Vincent per il giornalismo.
Dopo la sua morte sono state pubblicate due antologie degli articoli di Bruno Raschi: Ronda di notte – Storie personaggi e fiabe del Giro e del Tour, uscita nel 1984 e ristampata nel 2013 a cura di Beppe Conti, e Bella è la sera, a cura di Giuseppe Castelnovi e Marco Pastonesi, uscita nel 2008
Gli sono stati intitolati il palasport di Parma (PalaRaschi) e quello di Borgo Val di Taro.
** Riproponendo questo articolo, scoperto quasi per caso in una rivista poco conosciuta, abbiamo voluto rendere omaggio ad una figura importante del giornalismo sportivo italiano. Queste righe tracciano un quadro di quello che l’hockey rappresentava per giocatori, addetti ai lavori e tifosi negli anni ’50. Un quadro, a dire il vero, quanto mai attuale, per chi si è appassionato a questo sport nel corso dei decenni successivi a questa pubblicazione.